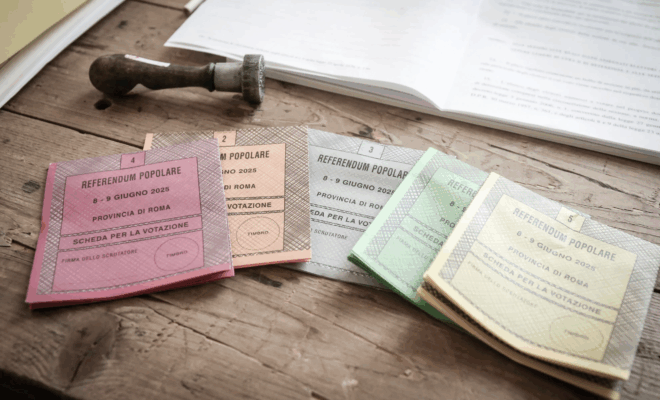Un racconto dal mondo della piccola impresa, un tratto caratteristico del capitalismo italiano

Riportiamo l’intervista a Paolo, operaio metalmeccanico di una piccola azienda della provincia di Reggio Emilia. Si porta all’attenzione del lettore il suo racconto perché ricco di situazioni tipiche nelle piccole-medie imprese: dalle contraddizioni derivanti dalla loro posizione all’interno della filiera produttiva, a certi aspetti ideologici, psicologici e comportamentali dei padroni e dei dipendenti, fino alla presa di coscienza, attraverso la propria condizione oggettiva, della necessità di una lotta di classe organizzata come unica strada percorribile verso l’emancipazione sociale individuale e collettiva. Nulla è scontato, bisogna fare tesoro di situazioni come questa: il compito dei comunisti, oggi, è anche quello di ampliarle, intensificarle, collegarle e indirizzarle, come premessa necessaria alla costruzione del socialismo.
Ciao Paolo, innanzitutto di che genere di azienda stiamo parlando?
L’azienda dove lavoro in realtà è un’azienda come se ne trovano tante altre nel nostro territorio: piccola impresa emiliana di produzione metalmeccanica. L’attuale padrone è il figlio del fondatore. Si producono utensili e attrezzerie varie, il personale attualmente ammonta a 9 dipendenti, per un totale di 11 persone.
Che idea ti sei fatto della situazione generale del tuo settore?
 La sensazione è quella di essere i piedi d’argilla sui quali si appoggia l’intera filiera produttiva dei colossi metalmeccanici. Clienti rinomati appaltano la realizzazione di componentistica ad aziende intermedie, le quali a loro volta appaltano a noi la produzione dei componenti più elementari e dell’attrezzeria necessaria. I clienti più grandi, in questo quadro, hanno il coltello dalla parte del manico: ad ogni spostamento dell’attività produttiva di quelli, tutta la catena dei fornitori oscilla pericolosamente, scaricando i sacrifici sui lavoratori che si trovano alla base. La forte concorrenza determina una battaglia al ribasso sui prezzi e così, per continuare il lavoro al servizio del grande cliente, si accettano delle condizioni che portano allo stremo l’attività produttiva.
La sensazione è quella di essere i piedi d’argilla sui quali si appoggia l’intera filiera produttiva dei colossi metalmeccanici. Clienti rinomati appaltano la realizzazione di componentistica ad aziende intermedie, le quali a loro volta appaltano a noi la produzione dei componenti più elementari e dell’attrezzeria necessaria. I clienti più grandi, in questo quadro, hanno il coltello dalla parte del manico: ad ogni spostamento dell’attività produttiva di quelli, tutta la catena dei fornitori oscilla pericolosamente, scaricando i sacrifici sui lavoratori che si trovano alla base. La forte concorrenza determina una battaglia al ribasso sui prezzi e così, per continuare il lavoro al servizio del grande cliente, si accettano delle condizioni che portano allo stremo l’attività produttiva.
Questa contraddizione interna alla filiera si somma all’atteggiamento tipico del proprietario della piccola-media impresa artigiana. Un egoismo che fa sì che per rientrare nei ritmi produttivi giornalieri i dipendenti rinuncino quotidianamente alla pausa pranzo; l’obbligo di straordinari non pagati (le otto ore giornaliere sembrano un’utopia che nell’artigianato non si è mai realizzata, nella totale assenza di controlli in merito); la rinuncia alle ferie in agosto per soddisfare la richiesta di un cliente arrivato improvvisamente. L’importante è che il proprietario riesca a garantirsi un buon profitto alla fine dell’anno.
Che tipo di atteggiamento noti nei lavoratori, rispetto a questa situazione che hai descritto?
In molti operai del mio settore si riproduce un preciso tipo di mentalità. In queste piccole aziende il padrone crea un clima di collaborazione e responsabilità, come l’essere parte di una famiglia, che lavora per un obiettivo comune, ovvero il risultato economico dell’azienda.
In un contesto aziendale di piccole dimensioni come il nostro, è palese come il contributo di ciascuno dei dipendenti sia fondamentale alla produzione: così i lavoratori maturano un senso di riconoscenza nei confronti dell’azienda, che sentono come qualcosa di loro, alla quale devono contribuire sacrificando il loro tempo libero, la loro tranquillità e anche la loro salute.
Però c’è un limite oltre il quale la responsabilità dell’operaio diventa servilismo verso il padrone e verso un sistema produttivo che lo calpesta quotidianamente. Noi subiamo le conseguenze della crisi produttiva e della concorrenza, ci adeguiamo alle decisioni del padroncino; lui invece, più “figlio bamboccio” che “buon padre di famiglia”, mantiene il suo stile di vita lussuoso, dando per scontati i sacrifici che ognuno di noi fa per ottenere il suo risultato economico. Se l’azienda è “casa sua”, ci sembra di esserne i soprammobili ornamentali: non solo ha la proprietà delle macchine di produzione e del prodotto da noi realizzato; ha anche la proprietà delle nostre vite e della nostra salute. L’emergenza COVID-19 non ha fatto altro che rendere tutto questo palese.
Come è stata gestita l’emergenza virus, in questo caso?
Nei primi giorni tutto è continuato come se niente fosse, come se il virus si fermasse al di fuori delle mura della fabbrica. In un ambiente di lavoro sociale, per garantire la tutela di ogni individuo è necessario che tutti i dipendenti siano dotati dei dispositivi necessari ad evitare il contagio.
Così è cominciata la mia lotta, in primo luogo per tutelare me stesso. Sono riuscito a trovare un pacchetto di mascherine, anche se non di quelle che prevengono il contagio, e ho insistito affinché tutti i dipendenti le utilizzassero. Ho effettuato personalmente e da solo, la sanificazione di spogliatoi, monitor e macchinari. Il martedì successivo, avevamo tutti la mascherina.
Il rischio di contagio, però, era ben lontano dall’essere scomparso. Anche applicando alla lettera il protocollo del 14 marzo siglato tra sindacati e imprenditori, attività lavorative come la nostra hanno, nelle modalità in cui necessariamente devono essere svolte, fasi che costringono gli operai ad avvicinarsi, oltrepassando la distanza minima imposta, già di per sé insufficiente. Diversi clienti ad esempio entravano in azienda sprovvisti di qualsivoglia dispositivo di protezione. L’attività produttiva, nelle date condizioni di emergenza, non garantiva la sicurezza ai dipendenti. Così abbiamo iniziato la seconda lotta: quella per la chiusura dell’attività, attivando la cassa integrazione.
 È stato difficile, anche perché le norme di sicurezza ci impedivano di svolgere assemblee. Fortunatamente, ho trovato il pieno appoggio da parte di altri tre colleghi. È stato il nucleo dal quale si è sviluppata una lotta a piccoli passi che ha guadagnato, infine, il consenso degli altri. Non tra poche difficoltà: linguistiche, per farsi capire dai colleghi stranieri; informative, per spiegare i rischi individuali e sociali della malattia e le caratteristiche conosciute in quel momento; persuasive, per convincere quelli che erano disinteressati alla questione e volevano, per principio, restarne indifferenti; pratiche, perché le manovre di convincimento avvenivano in maniera semiclandestina, tra borbottii e messaggi telefonici.
È stato difficile, anche perché le norme di sicurezza ci impedivano di svolgere assemblee. Fortunatamente, ho trovato il pieno appoggio da parte di altri tre colleghi. È stato il nucleo dal quale si è sviluppata una lotta a piccoli passi che ha guadagnato, infine, il consenso degli altri. Non tra poche difficoltà: linguistiche, per farsi capire dai colleghi stranieri; informative, per spiegare i rischi individuali e sociali della malattia e le caratteristiche conosciute in quel momento; persuasive, per convincere quelli che erano disinteressati alla questione e volevano, per principio, restarne indifferenti; pratiche, perché le manovre di convincimento avvenivano in maniera semiclandestina, tra borbottii e messaggi telefonici.
Nonostante queste problematiche, ci siamo riusciti. Con maniere decise, abbiamo convinto anche il padrone della necessità di fermare la produzione. Abbiamo chiamato il sindacato, che ha appoggiato la nostra richiesta. Il risultato che abbiamo ottenuto è stata la chiusura dell’attività per due settimane.
Quindi nel tuo caso si può certamente affermare che la mobilitazione, la lotta, hanno pagato.
Sì. Bisogna anche dire che, se non l’avessi iniziata, la lotta non avrebbe nemmeno avuto luogo. Forse in altre aziende, dalla condizione simile alla nostra, nessuno ha preso l’iniziativa, e si è continuato a lavorare nell’accettazione passiva delle condizioni imposte dal padrone. Quello che manca sono soggetti attivi, che prendano l’iniziativa nelle lotte sociali, che partano dai luoghi di lavoro, e che le portino avanti. Soprattutto, si sente la mancanza di un’organizzazione politica che le coordini, le rafforzi e le possa indirizzare. Forse è anche per questo che a molti manca il coraggio di combattere.
Finita una lotta, ne comincia un’altra. La sospensione delle attività produttive imposta dal decreto è una misura insufficiente. La mia azienda è un esempio di come si possa aggirare (e, di fatto, si stia aggirando) l’imposizione legislativa. Abbiamo due codici ATECO, uno primario e uno secondario. Grazie a ciò ci è consentito mantenere attiva la produzione, che a livello teorico dovrebbe essere legata solo alla filiera destinata al settore specifico. In pratica, la nostra azienda (come molte altre), approfitta dell’apertura per produrre tutt’altro, confidando sull’assenza di controlli.
Il padrone, perciò, ha fatto riprendere l’attività, sebbene non a pieno regime. Inizialmente, si recavano a lavoro lui e un altro collega, mentre gli altri alternavano giornate di lavoro a giornate di cassa integrazione, o ferie, per chi la cassa integrazione non se la può permettere avendo mutui e affitti da pagare. In quante piccole e medie aziende si vede, in questi giorni, il padrone recarsi al lavoro con il figlio, il parente, l’amico, mentre gli altri dipendenti vengono lasciati a casa? Anche questa forma di ingiustizia è una diretta conseguenza dello strapotere e della discrezionalità lasciata agli imprenditori, che si sentono liberi da obblighi sociali. Invece, questi obblighi andrebbero imposti da noi lavoratori, attraverso delle giuste lotte sociali. Così è stato. Siccome abbiamo rodato, uniti, un modello di protesta e convincimento efficace, anche questa lotta ha avuto successo: dalla prossima settimana, finché non si tornerà a pieno regime, abbiamo concordato una turnazione delle ore di cassa integrazione.
La situazione tornerà come prima?
Spero che niente torni come prima. È necessario ripensare completamente il modello produttivo, ribaltando la logica capitalista per la quale i mezzi di produzione devono appartenere a un privato e non alla collettività, con le conseguenze di strapotere e discrezionalità che in questa situazione sono tanto lampanti. La gente queste cose le deve capire, altrimenti tutto tornerà peggio di prima. Il rischio è proprio quello che, una volta finita l’emergenza, si chiedano ulteriori sacrifici ai lavoratori. I clienti che in questo periodo hanno avuto difficoltà economiche chiederanno di posticipare i pagamenti. Ne conseguirà certamente la mancanza di liquidità dell’azienda, con le conseguenze che, come di consueto, colpiranno i lavoratori. Ritardi nel pagamento degli stipendi, richiesta di orari straordinari e ritmi di lavoro estenuanti rischieranno di diventare la normalità. Come la situazione si risolverà, dipende soprattutto da noi lavoratori. Saremo pronti e organizzati?