La questione del parlamentarismo
Il II Congresso dell’IC, 19 luglio-7 agosto 1920, è in larga parte occupato dal dibattito sulla tattica rivoluzionaria e segnato dalla battaglia ideologica condotta da Lenin contro le posizioni estremiste presenti in alcuni partiti comunisti o correnti comuniste nei partiti socialisti.
Se all’interno della frazione comunista italiana, soprattutto tra la gioventù, è largamente predominante la posizione astensionista di Bordiga, Gramsci e L’Ordine Nuovo guardano al parlamentarismo in modo più consonante con il pensiero di Lenin e dell’Internazionale Comunista. Gramsci, infatti, così chiarisce la posizione ordinovista in relazione al successo elettorale del PSI nel 1919 e alla partecipazione al parlamento:
«La rivoluzione comunista non può essere realizzata con un colpo di mano … è necessario che l’avanguardia rivoluzionaria susciti, coi suoi mezzi e i suoi sistemi, le condizioni materiali e spirituali in cui la classe proprietaria non riesca più a governare pacificamente le grandi masse di uomini, ma sia costretta, per la intransigenza dei deputati socialisti controllati e disciplinati dal partito, a interrorire le grandi masse, a colpire ciecamente e a farle rivoltare. Un fine di tal genere può solo essere perseguito oggi attraverso l’azione parlamentare, intesa come azione che tende a immobilizzare il Parlamento, a strappare la maschera democratica dalla faccia equivoca della dittatura borghese e farla vedere in tutto il suo orrore e la sua bruttezza ripugnante»[1].
Gramsci concepisce la partecipazione alle istituzioni elettive borghesi, quindi, in un modo che impedisca che le masse proletarie
«siano illuse, che si faccia loro credere che sia possibile superare la crisi attuale con l’azione parlamentare, con l’azione riformistica. È necessario incrudire il distacco delle classi, è necessario che la borghesia dimostri la sua assoluta incapacità a soddisfare i bisogni delle moltitudini, è necessario che queste si persuadano sperimentalmente[2] che sussiste un dilemma netto e crudo: o la morte per fame, … o uno sforzo eroico, uno sforzo sovrumano degli operai e contadini italiani per creare un ordine proletario … Solo per questi motivi rivoluzionari l’avanguardia cosciente del proletariato italiano è scesa nella lizza elettorale, si è solidamente piantata nella fiera parlamentare. Non per un’illusione democratica, non per un intenerimento riformista: per creare le condizioni del trionfo del proletariato, per assicurare la buona riuscita dello sforzo rivoluzionario che è diretto a instaurare la dittatura proletaria incarnantesi nel sistema dei Consigli, fuori e contro il Parlamento»[3].
È impossibile non vedere la consonanza del pensiero di Gramsci con quanto Lenin scriverà un anno dopo, in aperta polemica con la “sinistra comunista”, rappresentata in Italia da Bordiga e in Germania dal KAPD (Partito Comunista Operaio di Germania, nato da una scissione dal KPD nel 1920):
«Il parlamento è un prodotto dello sviluppo storico che non possiamo cancellare dalla vita finché non saremo abbastanza forti da sciogliere il parlamento borghese. Solo facendo parte del parlamento borghese è possibile, partendo dalle condizioni storiche date, lottare contro la società borghese e il parlamentarismo. Quello stesso mezzo che la borghesia usa nella lotta deve essere usato anche dal proletariato, certamente con fini completamente diversi … Una parte della piccola borghesia proletarizzata, gli operai più arretrati, i piccoli contadini, sono tutti elementi che pensano effettivamente che in parlamento siano rappresentati i loro interessi; contro tutto ciò occorre battersi con il lavoro in parlamento e mostrare nei fatti la verità alle masse. Le masse arretrate non le convinci con la teoria, a loro serve l’esperienza[4] … Occorre sapere come distruggere il parlamento … ciò è impossibile senza una preparazione abbastanza lunga … nella maggior parte dei paesi non è ancora possibile distruggere il parlamento in un colpo solo. Siamo costretti a lottare in parlamento per distruggere il parlamento»[5].
 Nell’astensionismo e nel rifiuto dell’attività parlamentare, Lenin vede un segno di debolezza, organizzativa e ideologica, del partito proletario: «Se non preparerete gli operai alla formazione di un partito realmente disciplinato, che obblighi tutti i suoi membri a sottomettersi alla sua disciplina, non preparerete mai la dittatura del proletariato. Io penso che sia per questo che non volete riconoscere che è proprio la debolezza di molti nuovi partiti comunisti a portarli a negare il lavoro parlamentare»[6].
Nell’astensionismo e nel rifiuto dell’attività parlamentare, Lenin vede un segno di debolezza, organizzativa e ideologica, del partito proletario: «Se non preparerete gli operai alla formazione di un partito realmente disciplinato, che obblighi tutti i suoi membri a sottomettersi alla sua disciplina, non preparerete mai la dittatura del proletariato. Io penso che sia per questo che non volete riconoscere che è proprio la debolezza di molti nuovi partiti comunisti a portarli a negare il lavoro parlamentare»[6].
È interessante notare come sia Lenin che Gramsci insistano entrambi sul fatto che le sole argomentazioni teoriche da sole non sono sufficienti a combattere il parlamentarismo.
La finzione parlamentare, che sottende un democratismo fintamente universale, ma in realtà ad uso della sola classe dominante, può essere smascherata unicamente da un’azione rivoluzionaria, anche, ma non solo, sul terreno parlamentare, che dimostri empiricamente alle masse il carattere ingannevole dell’istituzione e di tutta democrazia borghese e ne vinca i pregiudizi e le illusioni in tal senso. In generale, in tutto il pensiero di Lenin è espressa con chiarezza la giusta convinzione che, al di là della natura in sé di questo o quel fenomeno, di questa o quella istituzione, è importante l’uso che il partito proletario deve farne per perseguire le proprie finalità rivoluzionarie. Non è tatticismo pragmatico, in quanto la questione travalica la tattica per assumere consistenza strategica nella necessaria corrispondenza ai principi rivoluzionari, a partire da quello, centrale, della dittatura proletaria e dell’assoggettamento ad essa di tutte le sfere delle relazioni e delle attività sociali. Pur sottolineando la giustezza della richiesta di Bordiga di espellere Turati e trasformare il PSI in un partito comunista di nome e di fatto, Lenin rileva:
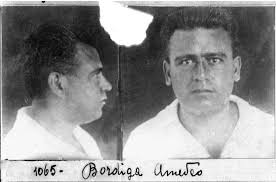
Amadeo Bordiga
“Il compagno Bordiga e i suoi amici di “sinistra” traggono dalle loro corrette critiche ai signori Turati e soci la conclusione sbagliata che la partecipazione al parlamento in generale sia dannosa. La “sinistra” italiana non può portare neppure l’ombra di argomenti seri a difesa di questo punto di vista. Semplicemente non conoscono (o cercano di dimenticare) esempi internazionali di uso veramente rivoluzionario e comunista dei parlamenti borghesi, indiscutibilmente utili per preparare la rivoluzione proletaria. Semplicemente non immaginano un “nuovo” uso e strillano, ripetendosi all’infinito, sull’uso “vecchio”, non bolscevico, del parlamentarismo. Questo è il loro errore fondamentale. Non solo in campo parlamentare, ma in tutti i campi di attività, il comunismo deve introdurre (e senza un lavoro lungo, persistente e ostinato non sarà in grado di farlo) qualcosa di fondamentalmente nuovo, di rottura radicale con le tradizioni della Seconda Internazionale (mantenendo e sviluppando ciò che essa ha dato di positivo). … L’infantilismo della “negazione” della partecipazione al parlamentarismo consiste espressamente nel fatto che in un modo così “semplice”, “facile”, apparentemente rivoluzionario, pensano di “risolvere” il difficile compito di combattere le influenze democratico-borghesi all’interno del movimento operaio, ma in realtà stanno solo fuggendo dalla propria ombra, stanno solo chiudendo gli occhi davanti alla difficoltà e se ne liberano solo a parole. Ma tutte queste “difficoltà” sono assolutamente infantili in confronto a compiti esattamente dello stesso genere, che il proletariato dovrà inevitabilmente risolvere per la sua vittoria sia durante la rivoluzione proletaria che dopo la presa del potere. Rispetto a questi compiti veramente giganteschi, quando in condizioni di dittatura del proletariato sarà necessario rieducare milioni di contadini e piccoli proprietari, centinaia di migliaia di impiegati, funzionari, intellettuali borghesi, subordinarli tutti allo stato proletario e alla direzione proletaria, sconfiggere le loro abitudini e tradizioni borghesi, rispetto a questi compiti giganteschi, creare, sotto il governo della borghesia, in un parlamento borghese, un gruppo parlamentare veramente comunista di un vero partito proletario è un gioco da bambini“[7].
Tuttavia, la questione della lotta all’opportunismo e al riformismo è considerata da Lenin prioritaria e più difficile rispetto a quella contro l’antiparlamentarismo astensionista che – non va dimenticato – è una tendenza internazionale della sinistra comunista di cui Bordiga è esponente di primo piano.
“L’opportunismo è il nostro principale nemico. L’opportunismo al vertice del movimento operaio non è socialismo proletario, ma socialismo borghese. È stato praticamente dimostrato che gli esponenti all’interno del movimento operaio che appartengono alla corrente opportunista sono difensori della borghesia migliori della borghesia stessa. … e dobbiamo vincere questo nemico. Dobbiamo uscire dal Congresso con la ferma decisione di condurre fino in fondo questa lotta in tutte i partiti. Questo è il compito principale. Rispetto a questo compito, correggere gli errori della tendenza “di sinistra” nel comunismo sarà un compito facile … In tutta una serie di paesi vediamo l’antiparlamentarismo, che non è portato tanto da elementi della piccola borghesia, quanto sostenuto da alcuni reparti avanzati del proletariato, per odio del vecchio parlamentarismo, per odio legittimo, giusto, necessario del comportamento degli esponenti parlamentari … la lotta contro questi errori del movimento proletario, contro questi difetti, sarà mille volte più facile della lotta contro la borghesia, che, sotto le spoglie dei riformisti, entra nei vecchi partiti della II Internazionale e dirige tutto il loro lavoro non in uno spirito proletario, ma in uno spirito borghese“[8].
Da queste e da altre affermazioni, si intuisce la diversa percezione che Lenin ha dell’opportunismo e dell’estremismo. Sono entrambe deviazioni dal marxismo, ma, mentre l’opportunismo è visto come un cancro incurabile da estirpare, un corpo per sua natura estraneo al movimento operaio, l’estremismo è considerato come una malattia esantematica infantile che bisogna combattere, ma si può curare.
Gli estremisti sono quella parte del movimento operaio che sbaglia, ma che è recuperabile, mentre gli opportunisti sono agenti della borghesia, quindi nemici irrecuperabili.
Quanto detto non deve lasciare intendere che Lenin e l’Internazionale Comunista ritengano il parlamentarismo un’istituzione accettabile e compatibile con il comunismo, né che concepiscano il lavoro parlamentare come assolutamente imprescindibile in qualsiasi situazione o, peggio, come sostitutivo del lavoro illegale e dell’insurrezione armata. È l’uso combinato di tutte le forme di lotta possibili, di lavoro legale e illegale, di azione parlamentare e di sovversione armata, valutato nella sua convenienza in base a una rigorosa analisi scientifica della concreta situazione reale, che permette la vittoria della rivoluzione. Nelle “Tesi sui partiti comunisti e il parlamento“, redatte da Bukharin e approvate dal II Congresso, la posizione del Komintern è chiarissima a questo proposito. Il parlamento borghese è solo apparentemente espressione di una “volontà popolare” che prescinde dalle classi, ma in realtà è uno degli strumenti d’oppressione controllato dal capitale; il parlamentarismo è una forma particolare dell’ordinamento statale e, come tale, è incompatibile sia con il comunismo, in quanto in esso non vi sono né classi, né potere statale, sia con il periodo di transizione al comunismo, la dittatura proletaria, in quanto in esso le vecchie classi dominanti sono escluse dal potere statale e non vi è più necessità della finzione della “volontà popolare”; poiché il parlamento è un importante ingranaggio dello stato borghese, come quest’ultimo non può essere conquistato, ma deve essere distrutto e sostituito. “Ne deriva che il comunismo può interessarsi solo di sfruttare le istituzioni dello stato borghese allo scopo di distruggerle“[9]. Chiarito che la lotta di massa deve consistere in un’escalation dell’azione che porti all’insurrezione e alla guerra civile, le Tesi sottolineano la necessità per il partito proletario di assicurarsi tutte le posizioni legali ancora praticabili, utilizzandole come centri ausiliari – dunque non primari – dell’attività rivoluzionaria e la tribuna parlamentare è una di questi, ma non ha un ruolo preminente, poiché la lotta per il potere si svolge principalmente al di fuori del parlamento. L’attività elettorale e parlamentare, quindi, non deve essere prevalente, ma complementare alle forme extraparlamentari di lotta deve essere concepita come strumento di coinvolgimento di quei settori di classe operaia ancora distanti dalla politica. L’antiparlamentarismo di principio, cioè il rifiuto categorico e assoluto di partecipare alle elezioni e all’attività parlamentare rivoluzionaria viene definito “semplicistico e infantile“, ma dall’ammissibilità teorica della lotta parlamentare “non consegue affatto che sia assolutamente necessario partecipare in ogni caso a determinate elezioni o sessioni parlamentari. Questo dipende da tutta una serie di condizioni specifiche. In certi casi può essere utile uscire dal parlamento … In certi casi può essere necessario boicottare le elezioni e scalzare con la forza tanto l’intero apparato statale borghese, quanto la cricca parlamentare borghese, oppure può essere necessario partecipare alle elezioni pur boicottando il parlamento stesso, ecc.“[10]. Il documento sottolinea come il boicottaggio delle elezioni o del parlamento sia appropriato quando sussistano le condizioni per un passaggio immediato alla lotta armata. Poiché, come detto, il centro di gravità politico sta nella lotta per il potere statale e questa si svolge fuori dal parlamento, la questione, in realtà, riveste scarsa importanza e non può essere messa sullo stesso piano della questione della lotta di massa per la dittatura del proletariato. Perciò l’Internazionale Comunista “sottolinea con la massima forza che essa considera un grave errore qualsiasi scissione … su quest’unica questione“[11].
L’occupazione delle fabbriche
Anche le occupazioni delle fabbriche, attuate in risposta alla serrata nazionale decisa dai padroni, si concludono con una generale sconfitta della classe operaia, questa volta ottenuta non con la repressione, ma con l’inganno. Il Partito Socialista e la CGL si trovano a dovere decidere come e dove condurre un movimento che, nei fatti, dimostra di essere ben più avanzato di coloro che dovrebbero dirigerlo. In base al patto d’unità d’azione tra le due organizzazioni, firmato nel 1918, il partito potrebbe assumere la direzione del movimento al posto della dirigenza sindacale e proclamare lo sciopero generale insurrezionale, ma il Consiglio Nazionale non decide in tal senso, respingendo le ventilate dimissioni dei vertici CGL e demandando al Direttivo Nazionale del sindacato la decisione sugli sbocchi a cui condurre il movimento. La linea delle dimissioni della dirigenza e dello sciopero generale non viene votata neppure da Togliatti e Terracini, in rappresentanza della frazione comunista, per paura che si tratti di una provocazione, messa in atto dai riformisti per screditare i comunisti agli occhi delle masse operaie, additandoli come responsabili dell’insuccesso di un’insurrezione che, in effetti, avrebbe dovuto essere supportata da un’organizzazione ben più solida, anche militarmente, rispetto a quella che essi avevano in quel momento. La decisione del Direttivo CGL è scontata. Grazie all’uso burocratico del meccanismo delle deleghe, i riformisti, minoritari tra i lavoratori, hanno la maggioranza nel Direttivo, che decide di limitare le rivendicazioni ad aumenti salariali e al controllo sindacale in azienda. Piegato il movimento su questa linea di cedimento, grazie alla mediazione del governo Giolitti che lavora di concerto con la CGL, le fabbriche vengono restituite ai proprietari in cambio di qualche spicciolo e della promessa, mai più mantenuta, di una legge che stabilisca il controllo sindacale nelle aziende. Il Biennio Rosso italiano finisce con questa pesante e definitiva sconfitta della classe operaia. Anni più tardi, Gramsci così ricorderà quelle vicende:
«Come classe, gli operai italiani che occuparono le fabbriche si dimostrarono all’altezza dei loro compiti e delle loro funzioni. Tutti i problemi che le necessità del movimento posero loro da risolvere furono brillantemente risolti. Non poterono risolvere i problemi dei rifornimenti e delle comunicazioni perché non furono occupate le ferrovie e la flotta. Non poterono risolvere i problemi finanziari perché non furono occupati gli istituti di credito e le aziende commerciali. Non poterono risolvere i grandi problemi nazionali e internazionali, perché non conquistarono il potere di Stato. Questi problemi avrebbero dovuto essere affrontati dal Partito socialista e dai sindacati che invece capitolarono vergognosamente, pretestando l’immaturità delle masse; in realtà i dirigenti erano immaturi e incapaci, non la classe. Perciò avvenne la rottura di Livorno e si creò un nuovo partito, il Partito comunista»[12].
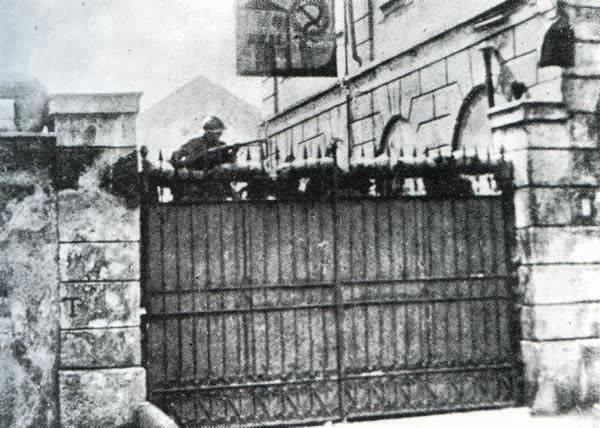 Le riflessioni sulla sconfitta del movimento di occupazione delle fabbriche danno un impulso ulteriore alla radicalizzazione anticentrista e all’unificazione delle componenti comuniste all’interno del PSI, di portata almeno pari, se non maggiore, a quello impresso dal II Congresso dell’Internazionale, accelerando il processo di avvicinamento dei rispettivi leader e di consolidamento dell’organizzazione.
Le riflessioni sulla sconfitta del movimento di occupazione delle fabbriche danno un impulso ulteriore alla radicalizzazione anticentrista e all’unificazione delle componenti comuniste all’interno del PSI, di portata almeno pari, se non maggiore, a quello impresso dal II Congresso dell’Internazionale, accelerando il processo di avvicinamento dei rispettivi leader e di consolidamento dell’organizzazione.
La scissione non è solo una questione di principio in rapporto all’adesione alla III Internazionale, ma ormai anche una necessità ineluttabile, dettata dal riscontro e dall’analisi delle insufficienze e delle negatività emerse nel Biennio Rosso e, soprattutto, negli eventi legati all’occupazione delle fabbriche, che si è rivelata essere più una tardiva reazione dei dirigenti riformisti della FIOM all’arroganza e alla rigidità padronale che non un autonoma iniziativa rivoluzionaria del proletariato organizzato.
Certamente era mancato un partito rivoluzionario, capace di dirigere e organizzare la classe e il suo movimento, di porre loro concreti obiettivi transitori e di collegarli alla prospettiva della presa del potere e al progetto di costruzione della democrazia sovietica, per cui gli effetti della collaborazione di classe e dell’aperto sabotaggio delle lotte da parte dei riformisti si erano sommati a quelli dovuti all’inconcludenza del rivoluzionarismo verbale massimalista. Questa situazione aveva finito per influire negativamente sulla combattività della classe operaia, logorata da mesi di scioperi senza risultati, ma soprattutto dalla perdita di fiducia nei suoi stessi istituti indipendenti, i Consigli di Fabbrica, lasciati privi di qualsiasi obiettivo di lotta. Alle deficienze della dirigenza socialista si aggiungono così carenze oggettive della stessa classe operaia, cioè localismi, corporativismi, disimpegno politico che, a poco a poco, ne inficiano lo spirito rivoluzionario che aveva nel 1919.
Il Komintern è convinto che l’occupazione delle fabbriche sia l’inizio della rivoluzione, cosa che, quando il movimento si esaurisce, lo induce a considerarla un’occasione mancata per difetto di direzione politica del PSI che non è riuscito a dare al movimento concreti obiettivi e prospettive di lotta, a collegare l’occupazione degli stabilimenti con la presa del potere che, secondo l’Internazionale, sarebbe stata possibile se non fosse intervenuto il tradimento riformista. Nella convinzione che l’Italia permanga in una situazione rivoluzionaria, l’IC preme quindi per accelerare i tempi della scissione.
L’analisi dei comunisti italiani è in parte diversa, anche per una migliore e diretta conoscenza degli eventi. I punti in comune sono le accuse alla dirigenza del PSI e le conclusioni sulla necessità della scissione, ma né Gramsci, né Bordiga considerano l’occupazione delle fabbriche come un’occasione rivoluzionaria mancata.
Piuttosto, Gramsci vi vede il punto massimo della capacità di mobilitazione delle masse in quel dato momento storico, a cui non può che seguire un riflusso.
 In lui si fanno strada anche dubbi sulla tenuta che avrebbe potuto avere un’ulteriore escalation delle lotte in senso rivoluzionario di fronte ad una reazione controrivoluzionaria e sono dubbi dettati non dal pessimismo che si usa attribuirgli, ma dalla consapevolezza del tradimento riformista, dell’inerzia massimalista, dell’impreparazione e della fragilità organizzativa della stessa frazione comunista. Questa constatazione rafforza in lui la convinzione che non si possa più rinviare la creazione di un partito rivoluzionario non a parole, ma a fatti, che veramente si ponga l’obiettivo della dittatura proletaria, che sappia agire senza tentennamenti e indecisioni nei momenti cruciali, che abbia un autentico ruolo dirigente delle masse. Gramsci ritiene l’unificazione dei comunisti ormai improcrastinabile e la convergenza con Bordiga imprescindibile. Su questo altare entrambi sacrificheranno alcune delle divergenze precedenti, Bordiga rinunciando alla discriminante astensionista, Gramsci accettando la sua leadership e l’impostazione schematica e dottrinale del partito che ne deriva. Tuttavia, non pochi sono i punti di contatto tra i due rivoluzionari, a partire dall’insistenza di entrambi sul concetto di disciplina, sia interna al partito che esterna, cioè del partito nei confronti dell’Internazionale Comunista. La mancanza di disciplina, di centralizzazione delle decisioni e l’autonomia dei partiti nazionali sono, giustamente, viste come la principale causa dell’egemonia che, di fatto, i riformisti riescono ad esercitare nel partito e nel sindacato, anche se numericamente minoritari. Per questa ragione il PSI continua a rimanere un partito secondinternazionalista che, anche se formalmente aderisce all’Internazionale Comunista, nei fatti non ne accetta i principi.
In lui si fanno strada anche dubbi sulla tenuta che avrebbe potuto avere un’ulteriore escalation delle lotte in senso rivoluzionario di fronte ad una reazione controrivoluzionaria e sono dubbi dettati non dal pessimismo che si usa attribuirgli, ma dalla consapevolezza del tradimento riformista, dell’inerzia massimalista, dell’impreparazione e della fragilità organizzativa della stessa frazione comunista. Questa constatazione rafforza in lui la convinzione che non si possa più rinviare la creazione di un partito rivoluzionario non a parole, ma a fatti, che veramente si ponga l’obiettivo della dittatura proletaria, che sappia agire senza tentennamenti e indecisioni nei momenti cruciali, che abbia un autentico ruolo dirigente delle masse. Gramsci ritiene l’unificazione dei comunisti ormai improcrastinabile e la convergenza con Bordiga imprescindibile. Su questo altare entrambi sacrificheranno alcune delle divergenze precedenti, Bordiga rinunciando alla discriminante astensionista, Gramsci accettando la sua leadership e l’impostazione schematica e dottrinale del partito che ne deriva. Tuttavia, non pochi sono i punti di contatto tra i due rivoluzionari, a partire dall’insistenza di entrambi sul concetto di disciplina, sia interna al partito che esterna, cioè del partito nei confronti dell’Internazionale Comunista. La mancanza di disciplina, di centralizzazione delle decisioni e l’autonomia dei partiti nazionali sono, giustamente, viste come la principale causa dell’egemonia che, di fatto, i riformisti riescono ad esercitare nel partito e nel sindacato, anche se numericamente minoritari. Per questa ragione il PSI continua a rimanere un partito secondinternazionalista che, anche se formalmente aderisce all’Internazionale Comunista, nei fatti non ne accetta i principi.
Dall’esperienza dell’occupazione delle fabbriche, dunque, i marxisti rivoluzionari italiani traggono importanti conclusioni di principio. La rottura totale con l’opportunismo e il riformismo della socialdemocrazia, che frenano e sabotano la rivoluzione proletaria, è condizione necessaria per la vittoria della rivoluzione stessa, ma non sufficiente: occorre anche che l’avanguardia di classe si organizzi in un partito di tipo nuovo, diverso dai vecchi partiti operai, un partito fortemente centralizzato, reso compatto da una ferrea disciplina, liberamente e coscientemente condivisa e da una verticalità di tipo militare, un partito di quadri rivoluzionari di professione che abbia, però, un forte collegamento con le masse e sappia agire in modo propositivo, con una tattica conforme alle linee strategiche del proprio programma politico generale.
Da frazione a partito: il Congresso di Livorno e la scissione.
Il 29 settembre 1920 si riunisce la Direzione del PSI, nella quale l’ordine del giorno di Terracini, che prevede l’approvazione dei 21 punti e delle tesi del II Congresso del Komintern, nonché l’espulsione dei riformisti, prevale a maggioranza sia sull’ordine del giorno dei massimalisti “centristi” Serrati e Baratono, che da qui in poi si definiranno “comunisti unitari” e sostengono l’unita e l’autonomia del partito, sia su quello dei riformisti di Turati, organizzati nella frazione “Concentrazione socialista”. Il fatto è di cruciale importanza, perché segna il punto di frattura definitiva con Serrati e i suoi che muterà radicalmente il carattere della scissione. Se fino ad ora questa è stata concepita, sia dagli italiani che dall’Internazionale, come scissione a destra, cioè come espulsione dei riformisti dal partito, è in questa occasione che incomincia a delinearsi l’eventualità, non ancora l’ipotesi, di una scissione a sinistra.
Il 15 ottobre 1920, a Milano, si unifica ufficialmente la frazione comunista, dopo che Bordiga ha rinunciato alla pregiudiziale astensionista e accettato la richiesta di Gramsci di stendere una piattaforma comune, con la pubblicazione di un manifesto-programma. La frazione raggruppa la componente bordighista, maggioritaria, la variegata componente ordinovista torinese, cioè i gramsciani dei “centri di educazione comunista” e i “comunisti elezionisti” (Togliatti, Terracini, ecc.), quella “social-comunista” di Anselmo Marabini[13] e quella operaista radicale milanese che fa capo a Fortichiari e Repossi. Nel manifesto-programma, che è sostanzialmente la traduzione dei deliberati del II Congresso del Komintern, si sottolineano i concetti di disciplina, subordinazione al Comitato Centrale e centralismo, epurato però dell’aggettivo “democratico”, cioè dell’elezione degli organismi dirigenti da parte della base (è il concetto bordighiano di “centralismo organico”), senza dire nulla circa i rapporti del partito con la classe e le masse, i Consigli e la democrazia consiliare come istituti basilari della dittatura proletaria, l’organizzazione per cellule nei luoghi di lavoro (raccomandate dall’Internazionale Comunista, non verranno mai costituite, a conferma della diffidenza, da parte di Bordiga, verso l’organizzazione per unità produttiva). Anche se le sue posizioni estremiste e la sua rigidità dottrinaria erano state ampiamente criticate da Lenin e respinte dal II Congresso del Komintern, è Bordiga il leader, l’ispiratore e l’organizzatore della frazione, ruolo che anche Gramsci gli riconosce. La Federazione Giovanile è con lui, la propaganda è nelle sue mani, ma è l’azione metodica e costante degli ordinovisti nelle fabbriche che porterà al futuro partito i primi nuclei operai militanti che costituiranno la base del PCdI.
Il Komintern sostiene pienamente e unicamente la frazione comunista, ma continua a rivolgersi a Serrati, affinché questi vi aderisca, se davvero vuole costruire un partito comunista in Italia. Non c’è nessuna doppiezza o ambiguità in questo, ma la preoccupazione che la scissione avvenga a destra, per assicurare ai comunisti l’acquisizione della maggioranza reale del partito, in piena coerenza con le tesi leniniane. La questione si sta rivelando essenziale, anche se non evolverà nella direzione auspicata dall’IC. Infatti, le scissioni a destra che avvengono nel Partito Socialdemocratico Indipendente di Germania (che nello stesso anno si fonderà con il KPD, dando breve vita al Partito Comunista Unificato di Germania, o VKPD) e nel Partito Socialista Francese portano all’Internazionale la maggioranza dei delegati, ma non la maggioranza degli iscritti, che continua a rimanere nei vecchi partiti. Tuttavia, la preoccupazione dell’IC per la conquista della maggioranza dei lavoratori socialisti alle posizioni comuniste spiega e giustifica la sua perdurante interlocuzione con Serrati nonostante il riconoscimento incondizionato della frazione comunista.

Giacinto Menotti Serrati
Le cose stanno diversamente per i comunisti italiani, delle cui aspre critiche Serrati è ormai il principale bersaglio. Bordiga considera ormai il “centrismo” come una particolare forma di opportunismo, ancora più subdola e pericolosa dell’opportunismo riformista e, a questo punto, il carattere della scissione, da destra o da sinistra, perde per lui qualsiasi significato. La scissione deve avvenire tanto dalla destra riformista, quanto dal centro massimalista: poco contano i rapporti di forza interni al partito, la scissione è una questione di principio che travalica le considerazioni tattiche e politiche del Komintern. È una posizione condivisa da quasi tutta la frazione comunista, Gramsci compreso, che successivamente porterà Togliatti a riconoscere che “La scissione di Livorno fu, essenzialmente e in prevalenza, un atto di lotta contro il centrismo … Noi combattevamo a fondo Turati e Modigliani, ma Serrati noi lo odiavamo … L’ostacolo principale non erano i riformisti, era il centrismo massimalista”[14]. La polemica con il PSI sarà talmente profonda, nei primi anni di vita del nuovo partito, da portare addirittura i massimalisti che confluiranno nel PCdI dal 1922 al 1924 a fare profonda autocritica, rinnegando di fatto il loro stesso passato nel PSI, ritenuto responsabile della sconfitta del “biennio rosso”. Persino Serrati, ormai membro del PCd’I, poco prima di morire definirà la posizione, da lui assunta a Livorno, come “il solo grande errore della vita: quello di avere autorizzato con le capacità e la buona fede un movimento che speravo di unità proletaria rivoluzionaria e che nascondeva di tutto, invece, tranne che del rivoluzionarismo”[15]. Il livore nei confronti del centrismo massimalista e di Serrati e la difficoltà a mutare atteggiamento spiegano sia la resistenza dei comunisti italiani all’esortazione di Lenin, solo un anno dopo la scissione, a riunirsi con i massimalisti terzinternazionalisti, sia la difficoltà a “digerire” la tattica del fronte unico. È un dato di fatto, comunque, che l’asprezza e la reiterazione degli attacchi a Serrati e al centro non favoriscono l’adesione dei militanti massimalisti alla piattaforma comunista.
Ciò che fa mutare l’atteggiamento dell’Internazionale Comunista nei confronti di Serrati è il fatto che la sua resistenza all’espulsione dei riformisti e per l’autonomia dei partiti nazionali lo trasforma nella bandiera di tutto il centrismo unitarista e autonomista che confluirà nella cosiddetta “Internazionale 2 e ½”, costituita a Vienna nel 1921, alla quale aderirà anche il PSI dopo la scissione comunista.
Al Convegno di Imola (28 novembre 1920) si giunge immediatamente dopo la conclusione di un’importante assemblea dell’organizzazione torinese del PSI, a cui partecipa anche Serrati, dove si crea la saldatura definitiva tra ordinovisti e bordighisti. Il gruppo de “L’Ordine Nuovo”, Gramsci per primo, ha deciso: senza Bordiga il partito comunista non si può fare e a questa convergenza devono essere subordinate tutte le discussioni sulle differenze tra i due gruppi. La mozione approvata a Torino non sancisce soltanto l’unificazione dei gruppi comunisti della sezione al segno della rottura con il “centrismo”, ma rappresenta lo sbocco, analitico e programmatico, del movimento rivoluzionario nel periodo del “biennio rosso”. Si definisce lo spartiacque tra i comunisti e i socialdemocratici, individuati in “coloro che pensano sia possibile effettuare seriamente il trapasso dal regime capitalistico al regime comunista integrale mediante coalizione con i ceti borghesi e prima, quindi, della conquista del potere politico da parte del proletariato”[16], si ribadiscono i Consigli di Fabbrica come istituzione sovietica della classe operaia italiana, si delinea il processo di costruzione del Partito Comunista come un processo di conquista dei lavoratori che, a partire dalle fabbriche, si estenda al sindacato, operando una netta distinzione rispetto agli anarchici, si prospettano i “circoli educativi” come sedi naturali dei gruppi comunisti e dei Commissariati di Zona dei Consigli di Fabbrica. Insomma, la mozione rispecchia il programma de “L’Ordine Nuovo”. Tuttavia, a Imola, di queste linee programmatiche rimane ben poco, a parte l’anti-centrismo. Emerge, comunque, la consapevolezza dell’urgenza della scissione, poiché la sconfitta del “biennio rosso” ha rivelato quanto tempo sia già stato perso prima di riuscire ad organizzare le forze rivoluzionarie. Le divergenze, dove esistono, devono essere accantonate in nome dell’unità con Bordiga, che, peraltro, apprezzerà molto il sostegno offertogli da Gramsci in questa occasione. Che si vada verso un periodo di esperienza socialdemocratica di accordo tra socialisti e partiti borghesi per la gestione della crisi, come erroneamente pensa Bordiga, oppure che la situazione rivoluzionaria possa ulteriormente svilupparsi, come ancora ritengono in molti, oppure ancora verso lo scatenarsi di una tremenda reazione borghese, come la III Internazionale e Gramsci incominciano a intuire, è comunque indispensabile raggruppare le forze rivoluzionarie per dotare il proletariato di quella “unità di combattimento” che era mancata nel “biennio rosso”. D’altronde, questa intuizione è suffragata dal fallimento dei tentativi rivoluzionari in Ungheria, in Baviera e in Germania, oltre che dalla sconfitta dell’Armata Rossa in Polonia.
Il Convegno di Imola decide la pubblicazione del nuovo organo della frazione, “Il Comunista”, elegge il proprio Comitato Centrale, nel quale sono rappresentate tutte le componenti, con preminenza di quella bordighista; ne fa parte anche Polano in rappresentanza della FGSI. La mozione finale non ha lo stesso spessore teorico di quella dell’assemblea di Torino – del resto, il Convegno ha finalità diverse, più organizzative -, ma è importante perché disconosce il patto tra PSI e CGL e sancisce il principio della subordinazione del sindacato al partito. A questo punto, i giochi sono fatti, il nuovo partito comunista è praticamente configurato ancora prima del Congresso di Livorno. In qualcuno resta aperta ancora la speranza di potere ottenere la maggioranza dei voti all’imminente XVII° Congresso del PSI, nella convinzione che le posizioni rivoluzionarie siano maggioritarie sia nel partito che nella classe. Anche l’Internazionale, del resto, è convinta che al prossimo congresso del partito Serrati e la maggioranza massimalista voteranno per la mozione comunista, come risulta dalle affermazioni di Zinoviev nella riunione del CEIC del 9 gennaio 1921. La storia dimostrerà che poi così non sarà, ma questo non cambiava il corso delle cose in quel momento: da destra o da sinistra, di minoranza o di maggioranza, la scissione è ormai un dato di fatto già prima del Congresso.
 Al XVII° Congresso del PSI, che si tiene al Teatro Goldoni di Livorno dal 13 al 21 gennaio 1921, lo scontro, soprattutto con i centristi, che pure ribadiscono l’adesione alla III Internazionale e l’accettazione dei 21 punti, rivendicando però autonomia nei tempi e nei modi della loro attuazione in relazione alle particolari condizioni dell’Italia, è durissimo. Nel messaggio di saluto al congresso, il CEIC, a firma di Zinoviev, ribadisce l’ultimatum:
Al XVII° Congresso del PSI, che si tiene al Teatro Goldoni di Livorno dal 13 al 21 gennaio 1921, lo scontro, soprattutto con i centristi, che pure ribadiscono l’adesione alla III Internazionale e l’accettazione dei 21 punti, rivendicando però autonomia nei tempi e nei modi della loro attuazione in relazione alle particolari condizioni dell’Italia, è durissimo. Nel messaggio di saluto al congresso, il CEIC, a firma di Zinoviev, ribadisce l’ultimatum:
“Il congresso del vostro partito sarà di enorme importanza per le sorti della rivoluzione internazionale … Riteniamo necessario dirvi ancora una volta, cari compagni, che l’Internazionale Comunista non ha e non vuole avere nulla in comune con quanti appartengono al campo riformista. Vi diciamo, con fermezza e con chiarezza: dovete scegliere tra Turati, D’Aragona e soci e la Terza Internazionale…“[17].
Per il Komintern la questione ha un’importanza che non è limitata al singolo PSI, ma è di rilevanza generale dal punto di vista strategico per la lotta contro l’opportunismo come tendenza internazionale e per la trasformazione dei vecchi partiti in partiti comunisti rivoluzionari.
Nonostante l’appoggio totale e inequivocabile delle tesi comuniste da parte del Komintern e dei suoi rappresentanti, Kabakčev, Rákosi e Balabanova, la mozione centrista, ottiene la maggioranza con 98.028 voti, quella riformista ottiene 14.695 voti, mentre quella comunista ne ottiene 58.783 (si tratta dell’espressione di voto degli iscritti rappresentati dai delegati, non di delegati come persone fisiche). Pur con questi rapporti di forza, Serrati e i suoi preferiscono allearsi con la minoranza riformista piuttosto che con la ben più consistente frazione comunista: una scelta che merita pienamente l’aspra critica di Lenin e del III Congresso dell’Internazionale Comunista e che, alla luce della separazione tra massimalisti e riformisti che avverrà l’anno successivo, appare irragionevole sotto tutti gli aspetti. Peraltro, questo fatto sposta l’asse della “responsabilità” della scissione, ammesso e non concesso che la questione possa essere posta in questi termini, così cari agli storici borghesi e agli opportunisti di oggi.
Quando, il 21 gennaio, vengono resi noti i risultati delle votazioni, Bordiga annuncia la scissione e convoca nel vicino Teatro San Marco la riunione dei delegati comunisti, che abbandonano la sala al canto de “L’Internazionale”. Dopo l’uscita dei comunisti dal Teatro Goldoni, il delegato massimalista Bentivoglio propone una mozione che ribadisce l’adesione del PSI all’Internazionale Comunista, accettandone senza riserva i principi e il metodo e si rivolge “in appello” al suo Comitato Esecutivo come ad un arbitrato, affinché nella sua prossima riunione a Mosca risolva, una volta per tutte e amichevolmente, il contrasto con i comunisti, con l’impegno del PSI di accettarne le decisioni come definitive e inappellabili. Sorprendentemente, la mozione passa all’unanimità, raccogliendo anche i voti dei riformisti e di Turati, che si trovano a dover riconoscere l’autorevolezza del Komintern. Il fatto è indicativo di come nel PSI, in quel momento, prevalga l’intenzione di non rompere con la III Internazionale, al di là delle divergenze che si ritengono componibili, nella già nota convinzione (sbagliata) che qualsiasi divisione indebolisca il movimento operaio. Al Congresso di Livorno, l’adesione del PSI alla III Internazionale viene riconfermata, ma viene anche ribadita la rivendicazione di autonomia del partito nell’interpretazione dei 21 punti, una posizione assolutamente inaccettabile per l’IC in quanto contraria al suo Statuto e ai suoi stessi principi fondativi. Dopo il congresso, il CEIC decreta l’espulsione del PSI dalla Terza Internazionale. La risoluzione del III Congresso dell’Internazionale Comunista, alla fine di giugno 1921, tuttavia, tiene conto della mozione Bentivoglio e stabilisce “… il terzo congresso mondiale dà istruzioni all’Esecutivo perché provveda a che vengano fatti i passi necessari per fondere il PSI, epurato degli elementi riformisti e centristi, con il PCd’I in una sezione unificata dell’Internazionale Comunista“[18]. È una posizione che incontrerà una forte contrarietà all’interno del neonato PCdI e non solo da parte di Bordiga, per via dell’asprezza del sofferto processo di separazione dal PSI, appena conclusosi.
Al Teatro San Marco si formalizza la costituzione del Partito Comunista d’Italia, nel cui CC figurano gli esponenti di maggior spicco di tutte le tendenze del comunismo italiano, sia pure con una netta prevalenza bordighista.
Gramsci non prende neppure la parola, a testimonianza di quanta distanza vi sia ancora tra l’autorevolezza e la popolarità di Bordiga rispetto a quella di Gramsci e di Togliatti. Ne esce un gruppo dirigente solo apparentemente coeso, come del resto è tutta la base del partito che, negli anni a venire, si assottiglierà. Il processo di costituzione del nuovo partito si completerà con l’adesione di quasi tutta la FGSI, 35.000 membri su 43.000, schierata anch’essa sulle posizioni di Bordiga. “L’Ordine Nuovo”, ora diretto da Togliatti, diventa l’organo del partito, al quale si affianca, a Trieste, un altro quotidiano comunista, “Il Lavoratore”, diretto prima da Tuntar e poi da Gennari. Lo statuto del partito è imperniato sul concetto di rigorosa disciplina e sulla subordinazione del singolo al collettivo e alle decisioni degli organismi dirigenti; è previsto un periodo di candidatura di sei mesi per i nuovi iscritti, ma tutti i membri sono sottoposti a periodiche revisioni di idoneità; è prevista la radiazione per chiunque sia assente ingiustificato a più di tre assemblee del livello organizzativo di appartenenza; stampa e gioventù sono sotto il controllo del CC, i Comitati Esecutivi locali dipendono direttamente dal Comitato Esecutivo nazionale, organismo collegiale di 5 membri, i segretari delle federazioni locali sono nominati dal CC; organizzazione di base è la sezione territoriale, voluta tale da Bordiga che temeva, sbagliando, che le cellule sui luoghi di lavoro potessero degenerare in entità corporative di tipo sindacale, permeabili ad ideologie non marxiste ancora presenti nel movimento operaio.
Nasce così il Partito Comunista d’Italia. Il nuovo partito, tuttavia, non avrà neppure un giorno da poter dedicare alla pacifica costruzione di consensi e adesioni. L’Italia sta per entrare in una fase di guerra civile, trascinata dalla reazione dei capitalisti e degli agrari, di cui il partito non ha ancora percepito la particolare e durevole natura. Gramsci, nel 1923, difendendo la linea del Komintern del “fronte unico”, porrà in correlazione l’ascesa del fascismo non con la scissione di Livorno in sé, ma con il “modo” in cui essa avvenne.
La scissione fu l’inevitabile prodotto della dinamica, nazionale e internazionale, della storica lotta tra comunismo e socialdemocrazia, ma la consistenza delle forze proletarie che l’azione dei comunisti in quegli anni riesce a portare sul terreno dell’Internazionale Comunista è ancora troppo esigua, insufficiente a fronteggiare la reazione.
Questo è il senso dell’autocritica che Gramsci propone al Partito: riconoscere e rimediare alle insufficienze e ai ritardi, accumulati durante il “biennio rosso” procrastinando troppo a lungo la scissione, con la costruzione di un forte partito comunista e abbandonare l’astrattezza e la dottrinalità dell’impostazione di Bordiga, che limitò la frazione comunista a “battere sulle questioni formali, di pura logica, di pura coerenza e, dopo non seppe, costituito il nuovo partito, continuare nella specifica missione, che era quella di conquistare la maggioranza del proletariato”[19]. La drammatica constatazione è però anche motivo di orgoglio:
“… travolti dagli avvenimenti, fummo, senza volerlo, un aspetto della dissoluzione generale della società italiana … avevamo una consolazione alla quale ci siamo tenacemente attaccati, che nessuno si salvava, che noi potevamo affermare di aver previsto matematicamente il cataclisma, quando altri si cullavano nella più beata e idiota delle illusioni. Solo questa giustificazione possiamo dare ai nostri atteggiamenti, alla nostra attività dopo la scissione di Livorno: la necessità che si poneva crudamente, nella forma più esasperata, nel dilemma di vita e di morte, cementando le nostre sezioni col sangue dei nostri più devoti militanti; dovemmo trasformare, nell’atto stesso della loro costituzione, del loro arruolamento, i nostri gruppi in distaccamenti per la guerriglia, della più atroce e difficile guerriglia che mai classe operaia abbia dovuto combattere. Si riuscì, tuttavia: il partito fu costituito e fortemente costituito; esso è una falange d’acciaio …”[20].
Considerazioni conclusive
Molte sono le lezioni che possiamo trarre dall’analisi delle vicende che hanno portato alla nascita del PCdI in particolare e dei partiti comunisti in generale, dal momento che si è trattato di un processo di carattere internazionale. Alcuni sviluppi delle situazioni di allora presentano affinità con quelle odierne che non si devono ignorare, anche se la storia non si ripete mai in modo perfettamente uguale, per ricavarne utile insegnamento. Molte questioni di allora conservano tutt’oggi la loro attualità, poiché sono ancora sostanzialmente aperte, sia pure nelle forme diverse che l’avanzare del tempo e il mutare delle condizioni oggettive determinano.
Occorre innanzitutto sottolineare, come il Komintern e i partiti che ne facevano parte, siano stati fucine di immensa progettualità politica e sedi di confronto e dibattito anche serrato e aspro, ma sempre libero e di altissimo livello.
La disciplina centralistica e quasi di tipo militare non inibiva mai la discussione analitica e il confronto di opinioni che devono precedere qualsiasi decisione e che, soli, garantiscono la composizione della sintesi più rispondente alla realtà e la condivisione della stessa disciplina.
La scissione di Livorno ha rappresentato, appunto, la sintesi nazionale, storicamente necessaria e inevitabile, della lotta internazionale contro l’opportunismo come tendenza all’interno del movimento operaio. Parlare di “responsabilità” soggettive quando si tratta, invece, di un evento direttamente determinato da ragioni e condizioni oggettive, interne ed esterne, è sbagliato, oltre che inutile.
Ugualmente, è da combattere con estrema decisione la posizione di chi accusa i comunisti di avere indebolito il movimento operaio con la scissione e di non avere voluto collaborare con la socialdemocrazia, favorendo così l’ascesa al potere del fascismo. Sono falsità, dettate da malafede politica, che cercano di ribaltare la storia per nascondere i veri, oggettivi genitori del fascismo, cioè il capitalismo e lo stato borghese con la complicità della monarchia e delle gerarchie clericali.
La Seconda Internazionale aveva appoggiato la carneficina della I Guerra Mondiale; i menscevichi avevano combattuto al fianco dei bianchi e degli interventisti contro il proprio proletariato; ancora la socialdemocrazia aveva sabotato la rivoluzione in Ungheria e in Germania, macchiandosi dell’assassinio di Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg e del massacro degli operai tedeschi; in Italia, il PSI e la CGL, che già avevano tradito e sabotato i moti operai del Biennio Rosso, il 3 agosto 1921 firmeranno il Patto di Conciliazione con i fascisti. Di fronte a fatti del genere e nelle condizioni date, nessuna unità era più possibile con la socialdemocrazia.
La necessaria separazione dagli opportunisti non ha indebolito, ma rafforzato il movimento operaio, eliminando dal suo interno gli agenti sabotatori della borghesia, dotandolo, a livello internazionale, di quei reparti d’avanguardia del proletariato, come il PCdI, che sono stati l’unica efficace opposizione al fascismo, in grado di operare clandestinamente nei propri paesi e di condurre la Resistenza armata, cosa che sarebbe stata impossibile senza le scissioni comuniste, a destra o a sinistra che fossero attuate.
La lotta all’opportunismo rimane centrale anche oggi, sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, dal momento che questa tendenza è oggi ampiamente diffusa anche nel Movimento Comunista Internazionale (MCI), dopo avere infettato, nel nostro paese, lo stesso PCI e i tutti i partiti che hanno cercato di assumerne l’eredità dopo il suo scioglimento. È difficile dire se una tempestiva scissione delle forze sane, ancora marxiste-leniniste, da quelle opportuniste, revisioniste e riformiste che con le prime convivevano nel PCI, fosse stata attuata nella sua fase eurocomunista anziché attendere la sua autodissoluzione, avrebbe potuto portare ad una situazione migliore, in termini quantitativi e qualitativi, di quella in cui oggi ci troviamo, ad una minore dispersione e debolezza dell’area comunista. Certo è che il confronto tra i dati sugli iscritti e i militanti di quegli anni e quelli di oggi rivela un distacco profondo del proletariato dalla politica attiva, frutto delle disillusioni e della sfiducia create proprio dalle deviazioni opportunistiche dei partiti che asserivano di rappresentarne gli interessi di classe e che, invece, erano solo preoccupati di mantenere i propri funzionari e i propri gruppi parlamentari dopo aver rinunciato alla rivoluzione per seguire la sola via delle elezioni e del parlamento. Come non vedere anche a questo proposito l’attualità del dibattito e delle indicazioni sulla tattica che in quegli anni il Komintern portava avanti?
Non meno importanti sono le riflessioni che le esperienze e le elaborazioni di quegli anni suggeriscono in merito all’unità e alle alleanze. La costruzione del partito comunista, oggi come ieri, non può realizzarsi per semplice sommatoria di gruppi, ma solo sulla base della condivisione dell’ideologia marxista-leninista e di un programma politico rivoluzionario, delle sue finalità e dei principi che lo animano, in uno stretto e fecondo rapporto con la classe operaia e le sue lotte, delle quali deve saper essere elemento di stimolo e avanguardia dirigente, organizzando le masse e ponendo loro chiari obiettivi transitori che consentano uno sviluppo rivoluzionario della lotta di classe. Significa avere la capacità di essere davanti agli eventi, non in coda ad essi. Questo è un altro importante insegnamento che ci viene dalle esperienze di quegli anni ormai lontani e che il nostro partito, il Fronte Comunista, fa proprio.
Se i partiti comunisti hanno saputo resistere e vincere il fascismo è soprattutto grazie al legame che essi avevano con l’Internazionale Comunista. La necessità di un coordinamento internazionale dei partiti comunisti è anch’essa più che mai evidente oggi, soprattutto dopo la temporanea vittoria della controrivoluzione in URSS e nei paesi socialisti. Certamente, oggi non sono ancora mature le condizioni per ripristinare il livello di coordinamento centralizzato e vincolante che aveva la Terza Internazionale: nel MCI manca quell’omogeneità ideologica e di principi che allora esisteva e ne garantiva la coesione prima ancora degli strumenti disciplinari; sono ancora troppo radicate in molti partiti le tendenze all’autonomia da un unico centro, suscitate dalla teoria delle “vie nazionali al socialismo”, sancita dal XX° Congresso del PCUS ed esasperata dall’eurocomunismo, che è servita da veicolo dell’opportunismo a livello internazionale; manca, infine, la base materiale di uno stato proletario che possa sostenere e ospitare un centro di coordinamento internazionale.
Se è vero che tali condizioni per ora non esistono, è altrettanto vero che dobbiamo lavorare attivamente per crearle: questo è il segno dell’impegno e della funzione che il Fronte Comunista intende assumere all’interno del MCI, al fianco di quei partiti che ne costituiscono la parte più avanzata e coerentemente marxista-leninista.
Guido Ricci è Membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Fronte Comunista e responsabile della Commissione Internazionale del CC del Fronte Comunista
________________________________
[1]A. Gramsci, I rivoluzionari e le elezioni, “L’Ordine Nuovo”, 15 novembre 1919
[2] Sottolineatura nostra
[3]Ibidem
[4] Sottolineatura nostra
[5]V.I. Lenin, Discorso sul Parlamentarismo, tenuto al II Congresso dell’Internazionale Comunista, agosto 1920, Opere Complete, vol. 41, p. 255-259, Ed. Političeskaya Literatura, Mosca, 1967
[6]Ibidem
[7]V.I. Lenin, Conclusioni sbagliate da giuste premesse, appendice a L’Estremismo, malattia infantile del comunismo, Opere Complete, vol. 41, p. 98-102, Ed. Političeskaya Literatura, Mosca, 1967
[8]V.I. Lenin, Sulla situazione internazionale e sui principali compiti dell’Internazionale Comunista, Rapporto al II Congresso dell’Internazionale Comunista, v. 41, p. 232, Ed. Političeskaya Literatura, Mosca, 1967
[9]Tesi sui partiti comunisti e il parlamento, 2 agosto 1920, Protokoll, II, p. 466, cit. in: J. Degras, Storia dell’Internazionale Comunista attraverso i documenti ufficiali, vol. 1, p. 168
[10]Ibidem, p. 169
[11]Ibidem, p. 170
[12]A. Gramsci, L’Unità, 1º ottobre 1926, Ancora delle capacità organiche della classe operaia
[13]Anselmo Marabini è un dirigente socialista emiliano, protagonista delle lotte contadine. Vicino al massimalismo e preoccupato di non perdere l’adesione di quanti, pur simpatizzando per l’Internazionale Comunista, hanno sempre dimostrato il proprio impegno sincero nelle file del PSI e a questa tradizione sono legati, propone l’adesione piena ai 21 punti dell’IC e il cambiamento di nome del partito in “Partito Socialista Comunista d’Italia”. A sostegno della Circolare Marabini-Graziadei si dichiareranno anche gli operaisti milanesi e diverse sezioni locali del PSI. Nel clima di aspra ostilità nei confronti di Serrati, la sua proposta verrà considerata come un ponte verso i centristi e quindi respinta dalla maggioranza della frazione
[14]P. Togliatti, La Nostra Esperienza, “Lo Stato Operaio”, a. V, n. I, gennaio 1931, p. 6
[15]G. Menotti Serrati, Vane difese massimaliste, “L’Unità”, 25 aprile 1926
[16]La mozione è integralmente riportata in un rapporto del Prefetto di Torino del 28 novembre 1920 (ACS, Ministero Interno, Direzione Generale di PS, G. I, b. 63)
[17]Lettera del CEIC al Congresso del PSI, gennaio 1921, K.I., 16, col. 3805, cit. in: J. Degras, Storia dell’Internazionale Comunista attraverso i documenti ufficiali, vol. 1, p. 227-228
[18]Risoluzione del III Congresso del Komintern sulla relazione del Comitato Esecutivo, 29 giugno 1921, Protokoll, II, p. 408, cit. in: J. Degras, Storia dell’Internazionale Comunista attraverso i documenti ufficiali, vol. 1, p. 247
[19]A. Gramsci, Contro il pessimismo, “L’Ordine Nuovo”, 15 marzo 1924
[20]Ibidem









